In tv mi imbatto talora in fiction con investigatori, anche in chiave nostrana, alla James Bond, alla Rambo, Superman, istrioni, macchiette… Allora penso a Roberto Mancini, e lo abbraccio con i tanti poliziotti sconosciuti, che sudano e soffrono ogni giorno tutelando la sicurezza di tutti, e facendo magari grandi i loro capi, politici, scrittori, registi e produttori… Ma chi lo conosceva, Roberto, prima del libro Morto per dovere (Luca Ferrari, Nello Trocchia, Monika Dobrowolska Mancini, Chiarelettere editore) o del film (Io non mi arrendo) interpretato da Beppe Fiorello? Neppure io. Finché a Roma in una sala del CNEL ho ascoltato la storia di questo “poliziotto di strada” che capelli non ne aveva più, portati via dalla chemio per il linfoma che aveva contratto combattendo per anni i rifiuti tossici della “terra dei fuochi” in Campania.

Morto per dovere (Luca Ferrari, Nello Trocchia, Monika Dobrowolska Mancini, Chiarelettere editore).
Leggendo il suo libro, mi piace pensare che Roberto Mancini si fosse persuaso a fare il poliziotto per l’aria nuova che cominciava a respirarsi. Terminato a Roma lo scoppiettante liceo Augusto, aveva deciso di entrare in polizia proprio a cavallo degli anni ‘80 quando la riforma di polizia stava diventando la legge 121/81. Dovevano essersi meravigliati i suoi compagni del collettivo di sinistra in cui militava. Forse lo avevano anche sfottuto, qualcuno gli aveva tolto il saluto, quando li aveva informati che sarebbe stato uno “sbirro”. Ma, doveva avere assicurato: “Non metterò il cervello all’ammasso!”.
C’erano “poliziotti” (doveva sentirlo intimamente) che ormai la pensavano diversamente, che si ribellavano alla stantia gerarchica e fascistoide; che la battaglia per cambiare le cose poteva farsi dall’interno! Al giuramento di fine corso, era arrivata la famiglia al completo, persino lo zio Betto, comunista pestato dai neri, che mai avrebbe immaginato di trovarsi lì, in una caserma ad applaudire il nipote, di sinistra, ora guardia in divisa. Aveva dovuto fare la gavetta, non di rado osteggiato da qualche collega, che mal digeriva quel suo giornale, “il manifesto”, esibito sotto l’ascella, i suoi modi scanzonati, spavaldi, sindacali.
Mentre leggevo il suo libro, pensavo ai miei poliziotti carbonari degli anni ’70 a Genova, alle nostre riunioni clandestine, agli scontri di piazza, agli anni di piombo, di terrore, di morte. A come avevamo avuto la sorte di incontrarci con quella stessa scintilla che aveva fatto scrivere a Pier Paolo Pasolini che a Valle Giulia nel 1968 che: lui era dalla parte dei poliziotti, non dei figli di papà”. Roberto Mancini, ne ero convinto, aveva raccolto quella scintilla!
Aveva cominciato il suo lavoro, senza ossequio verso i suoi superiori, ostinato e amante delle sue indagini. Aveva dovuto abbozzare, facendo finta talora di non sentire i borbottii di certi colleghi che sussurravano mentre passava: “ecco, ci siamo messi il nemico in casa”.
Era passato da incarichi quasi mortificanti, come badare alle macchine dell’autorimessa, giungendo a essere assegnato al Centro Interprovinciale Lazio – Umbria – Abruzzo, investigando da solo o con una piccola squadretta. Ed era presto diventato il più giovane viceispettore di polizia. Era brontolone, ma sapeva il fatto suo e i suoi uomini avevano cominciato a rispettarlo e a volergli.
A scorrere la sua storia attraverso il libro, lo si ritrova in indagini delicate su infiltrazioni camorristiche nel basso Lazio. È lui a seguire quelle che portano alla cattura di Ciro Mariano, boss dei quartieri spagnoli che ricicla a Roma i proventi della camorra investendo in attività commerciali e finanziarie. E lo si ritrova nell’arresto di boss catanesi cha fanno scorrere nei quartieri bene della capitale fiumi di cocaina. Luciano Rosini, che fu suo capo alla Criminalpol, lo ricorda: “Era un ottimo investigatore, anche se per ogni incarico brontolava, ma poi lo portava a termine egregiamente”, e gli riconosce il merito di avere indagato Roberto Moccia, boss di Afragola designato da Carmine Alfieri come il leader della Nuova Famiglia, antagonista della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.
Leggere le informative di Roberto Mancini, dà la misura della sua capacità di interpretazione del salto che sta avvenendo nel mondo della criminalità del basso Lazio. “Le organizzazioni di stampo mafioso o camorristico, si avvalgono di mezzi legali (come le società commerciali interessate alle più svariate attività) per riciclare il provento delle attività illecite”. Svolge anche rischiose attività da infiltrato, che portano a importanti risultati. È il periodo in cui nel Lazio si sta combattendo una guerra di occupazione tra varie consorterie, dagli eredi di Frank Coppola a Pippo Calò, dai faccendieri Flavio Carbone a elementi massonici, ai consulenti legali della camorra. E tra questi si imbatterà con Cipriano Chianese nelle indagini che porteranno alla chiusura della Banca industriale del Lazio di Cassino che doveva diventare il crocevia del riciclaggio del clan dei casalesi.
“In quegli anni, scrive nella sua informativa, le formazioni camorristiche del napoletano e del casertano fanno il loro ingresso nel business del traffico di rifiuti”.
Insomma Roberto Mancini, il poliziotto col “manifesto” sotto il braccio, ha intuito un’attività imprenditoriale criminale di dimensioni enormi di cui pochi avevano sentore: l’ecomafia. Ma sono visionari, pazzi? Roberto Mancini e i suoi ragazzi si sono messi in mente di indagare sulla “monnezza”. Ha visto giusto. È tutto nella frase che nel 1992 il boss pentito Nunzio Perrella aveva detto agli inquirenti: “La monnezza è oro dottò, e la politica è una monnezza”.
Il lavoro di Mancini è minuzioso, unisce punti che sembrano distanti: l’associazione mafiosa, l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. In quel periodo di buio normativo, non esisteva il traffico illecito di rifiuti e quelli ambientali non erano inseriti nel codice penale! Lui dirige una sottosezione di pochi uomini, meno di una decina, al Centro interprovinciale Criminalpol e non sempre va d’accordo col suo funzionario. Raccoglie elementi, collegamenti, come un computer, fa sopralluoghi… “Lui era il nostro genio, noi eravamo degli ectoplasmi, ma abbiamo messo l’anima in quell’indagine”, racconta uno dei suoi uomini.
L’informativa redatta nel 1996 da Roberto Mancini viene trasmessa dal suo dirigente Cavaliere all’Antimafia distrettuale. Ma non ha seguito. Ma Roberto non fa solo indagini di note, appunti, relazioni e computer; si muove, pedina, respira, scava, viene a contatto con sostanze. Collabora con la Commissione rifiuti della Camera, fa missioni e sopralluoghi in Italia e all’estero, si espone ai rifiuti tossici e alle loro esalazioni. Comincia a non sentirsi in gran forma. È debole, ma continua. E paradossalmente, proprio mentre interviene per una rapina, si sente poco bene, e decide a farsi delle analisi. Ne porta i risultati al suo medico: “25.000 piastrine invece delle normali 300.000”. Il medico lo rimprovera, gli impone di riposarsi. Risponde: “Come faccio a lasciare soli i miei ragazzi?”.
Nel 2010, racconta la moglie, scopre dei gonfiori sotto l’ascella. L’analisi è spietata: tumore non-Hodgkin. Inizia il calvario, le cure, il trasferimento a uffici più quieti: la Polfer, dove entra in contrasto con il dirigente che lo vuole in divisa. Lui che non l’ha mai portata! E quindi i trapianti, prima dal fratello minore, poi eterologhi. Momenti di sconforto, ma non vuole arrendersi. Lo aiuta la moglie, si fa aiutare da uno psicologo. Vuole combattere, non può mollare, specie ora che è diventato padre di una bella bambina! “Se ti fai prendere dalla malattia, muori prima. Tu non sei la tua malattia!”, si incoraggia.

Roberto Mancini (Roma, 1960 – Perugia, 2014) è stato il primo poliziotto che con la sua squadra ha indagato sullo sversamento illegale di rifiuti speciali e tossici nei territori della Campania, che verranno poi indicati come Terra dei fuochi, e sulle attività della camorra collegate.
Sono passati gli anni. La realtà della terra dei fuochi è sotto gli occhi di tutti. La sua informativa viene rispolverata da un magistrato che lo va a sentire in ospedale. E lui inizia a lavorarci. È una soddisfazione tardiva. “Voglio credere che i tempi non fossero maturi e che l’opinione pubblica non fosse pronta”, si conforta. Ora può riprendere a lavorarci, a casa, in ospedale. Ma le forze fuggono. Anche se racconta un collega che amareggiato cercava di confortarlo, lo aveva rimproverato scherzosamente: “Ao! Che te stai ad amalgamà? Che te voi arrenne?”.
Nel 2010 il Comitato di verifica del Ministero delle Finanze mette nero su bianco che la sua malattia viene da una “causa di servizio”, l’indennizzo, 5.000 euro. Il valore di una vita! Il caso diventa una manifestazione in piazza Montecitorio, con una petizione. Roberto Mancini muore il 30 aprile 2014.
I promotori la consegnano alla Camera, che poco dopo invia al Ministero dell’Interno tutta la documentazione relativa alle indagini di Roberto Mancini sui rifiuti tossici.
In due decenni un fiume di pattume si è riversato nel cuore fertile della terra campana. Rifiuti di ogni genere, gli scarti dell’Italsider di Taranto, la calce spenta dell’Enel di Brindisi e di Napoli, gli scarichi dell’Acna di Cencio, i rifiuti di tante aziende del settentrione. Il pentito Gaetano Vassallo in un processo racconterà: “Quando aprivamo le cisterne e scaricavamo i liquidi, i topi morivano stecchiti”.
Nel settembre 2014 a Roberto Mancini viene riconosciuto lo status di “vittima del dovere” che non solo certifica la connessione tra la malattia e il servizio prestato ma riconosce alla famiglia il diritto al sostegno previsto dalla legge.
Roberto ha lasciato la moglie Monika e una figlia, Alessia, adolescente. Ha scritto Monika nel messaggio di ringraziamento a chi l’ha aiutata nelle sue battaglie: “Non ci sono medaglie d’oro al valor civile né risarcimento che possano restituire l’affetto perduto ma il suo importantissimo lavoro sul traffico di rifiuti tossici è servito a molte cose e adesso il suo lavoro è ufficialmente riconosciuto. È giusto che chi ha dato la propria vita per il bene di tutti, venga almeno omaggiato dalle Istituzioni”. Il minimo che si possa per uno che aveva lottato per la legalità e avrebbe sempre continuato a farlo. Per un poliziotto di luce!
Al termine della presentazione del libro, senza parole ero corso ad abbracciare la mamma Giovanna, la moglie Monika, la figlia Alessia, il fratello Fabrizio e il nipotino Emiliano. Andando via con gli occhi lucidi, mi ponevo le domande: chi in alto aveva bloccato le sue indagini? Quanti morti si sarebbero evitati? Quanti madri e bambini dovranno ancora morire per tumore da rifiuti tossici? Chissà se ci sarà mai una risposta. Significativa quella che apre il libro a lui dedicato.
(Wangari Muta Maathai)
![]()
Dalla collana Poliziotti di Luce:
- Su Giannella Channel sbarcano le storie dei Poliziotti di luce
- Agostino Mastrodicasa, versi di un eroe normale
- Questo era Lillo Zucchetto, poliziotto onesto alle prese con i misteri di Palermo
- In morte di un commissario in prima linea: Ninni Cassarà
- “Carabinieri per la democrazia”. Un libro che fa luce sulle vite dei carabinieri uccisi dai terroristi




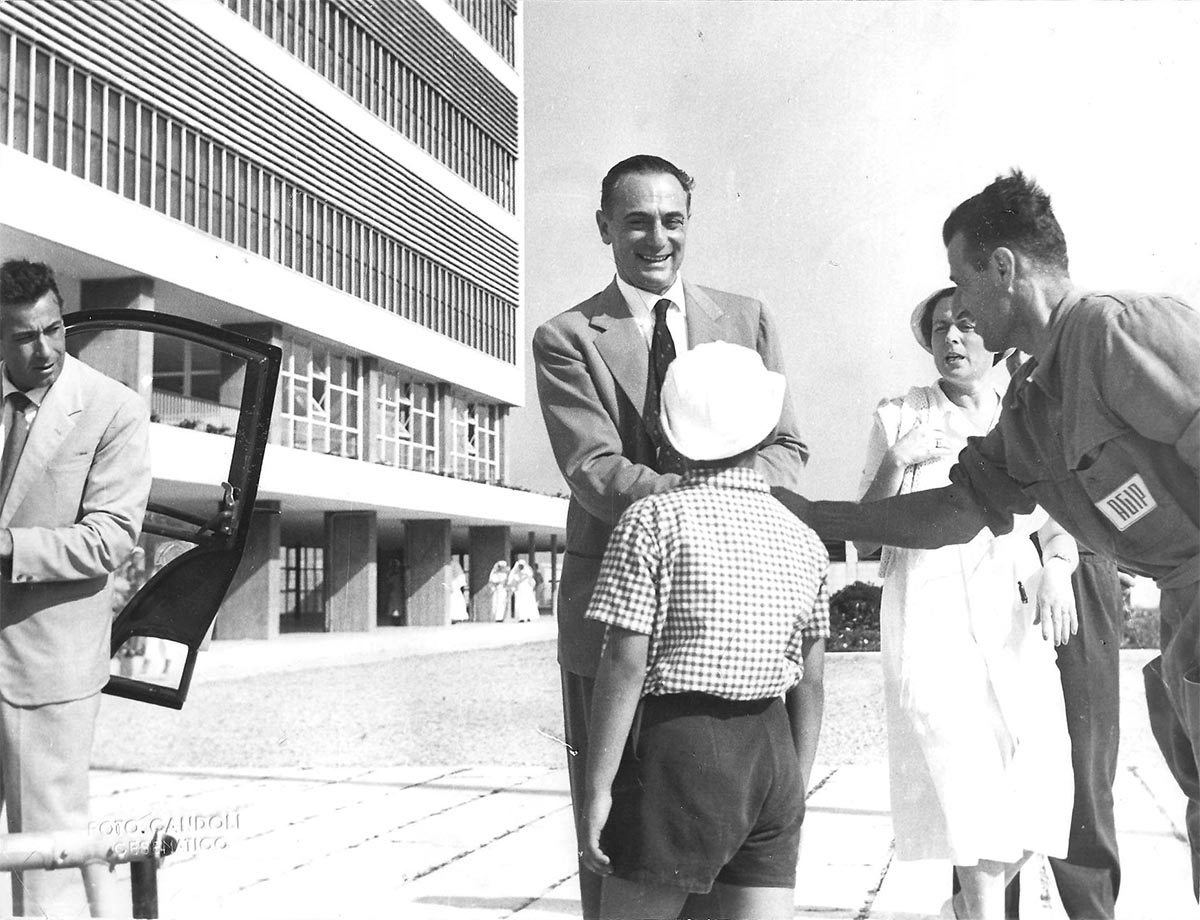





Bellissimo il tuo ricordo del poliziotto col manifestio sottobraccio, E complimenti per la foto coi nipotini. Mi ha fatto venir voglia di imitarti, però ho il problema dell’inquadratura: il primo è due metri… Ciao,
Camillo