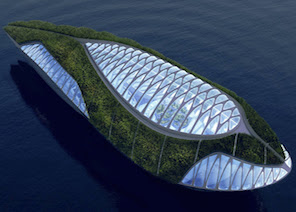Giancarlo Santalmassi (Roma, 1941).
Ha lavorato a Panorama, al Tg2 e a Rai3.
Ha diretto il giornale Radio
ed è stato direttore di Radio 24.
Ho conosciuto Miguel Mora 12 anni fa. Abbiamo legato subito. E non perché abitasse in Prati girato l’angolo di casa mia. Ma perché era uno dei migliori corrispondenti dall’estero (per il quotidiano spagnolo El Pais) da Roma. La nostra è diventata subito una amicizia profonda, consolidata da stima e fiducia. Con sei mesi di anticipo sulla scadenza della sua corrispondenza fu brutalmente e bruscamente trasferito a Parigi senza preavviso. In altri tempi sarebbe successo il finimondo: questa volta no. Ma per la nostra professione era solo l’inizio. Giorni fa è andato in Puglia (leggendo capirete perché) invitato a tenere una conferenza. Ha fatto un breve discorso. A parte la citazione del sottoscritto che ormai è vecchia di otto anni, vi consiglio di leggerlo. È un documento struggente sullo stato della nostra professione. (g. s.)
I tappeti, i discorsi e le cravatte non si addicono particolarmente ai giornalisti. Trascorrere anche poche ore in un luogo in cui non è possibile fumare, dove non c’è una macchina da caffè o un computer a portata di mano è quasi una tortura. La verità è che sono comunque emozionato e particolarmente grato ai responsabili del liceo, a Luisella e a Silvia per avermi invitato a Bari e a Trani. Sono stato qui alcuni anni fa, quando ero corrispondente in Italia.
Venni a intervistare Nichi Vendola e una giovane prostituta di nome Patrizia D’Addario. La faccenda risultò alquanto interessante anche se l’epilogo fu piuttosto triste: Vendola si diresse a Raffaele Fitto con un aggettivo irripetibile, lui ovviamente si arrabbiò e sporse querela contro il suo rivale politico e contro di me. Così lasciai Trani con una denuncia che risulta ancora pendente. L’intervista alla D’Addario in compenso fu un successone: fu trasmessa durante il programma di Michele Santoro e tutta Italia conobbe il bunga bunga…
L’unica nota stonata di questo mia nuova visita a Trani è che sarò costretto a propinarvi un breve discorso. Iniziamo allora….
La carne del cronista è in vendita. Come tutti ben sapete, da qualche anno ormai è diventato di moda sostenere che i giornali siano in via di estinzione e che i giornalisti non se la passino di certo meglio. Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione dei paradigmi industriali, dall’inchiostro di Gutenberg alla mela di Steve Jobs e, a coronamento del tutto, c’è anche la crisi economica insieme a quell’altra crisi, quella reale, peggio della peste per il nostro settore. Le dimissioni non fanno più notizia, la carne del cronista è in svendita e i moderni populisti approfittano della situazione per dare il colpo di grazia all’informazione. O almeno per mantenerla al proprio servizio. Conseguenza di tutto ciò è che la qualità della stampa e delle democrazie perde sempre più sostanza e prestanza agli occhi dei più.

Miguel Mora, giornalista di El Pais.
Ieri corrispondente da Roma, oggi da Parigi (@mikelemora).
Come consolazione generale non ci resta che il web, l’etere. Nuova panacea, Internet è il primo dei nostri pensieri, pronto a colmare tutte le mancanze che siano di spazio, di talento o personali. Oggi le storiche testate mondiali sono un gigantesco bazar-contenitore, un buco nero colmo di notizie istantanee. Notizie talmente veloci che noi giornalisti dobbiamo farci in quattro per riuscire a consegnarle in tempo possibilmente senza errori di ortografia. Per non parlare del tempo che ci vorrebbe per riscontrarle queste notizie. Talmente tante che non esiste persona capace di riconoscerle e reperirle nell’immensità di questo spazio digitale.
Troppe notizie uguale a nessuna notizia. Il mio amico Giancarlo Santalmassi, maestro di giornalismo e vittima di rappresaglie da parte di questo grande statista di nome Silvio Berlusconi, ha scritto nel suo blog (cito testualmente): “La società della comunicazione non coincide con la società della conoscenza. Troppe notizie uguale a nessuna notizia. Oggi il monopolio delle news non ce l’ha nessuno. Arrivano gratis per sms. L’editore puro è inesistente. E il lettore fatica a districarsi tra le notizie vere, le presunte, le false. È sempre più difficile capire se è importante e quanto quello che ti stanno raccontando”. Fine della citazione.
Forse stiamo vivendo l’ultima era glaciale del giornalismo classico. Forse, oggi, noi giornalisti siamo dinosauri in via di estinzione. O forse siamo astronauti sul punto di conquistare il pianeta Marte. Tutto corre così maledettamente veloce che diventa difficile capirlo. A volte ci sembra di aver scoperto l’America. Altre, invece, sembrerebbe quasi che siamo qui a scrivere il nostro stesso necrologio.
Siccome in questo mestiere tutto è già stato inventato, non sarebbe di certo cosa strana che un pennino riuscisse a scrivere il proprio necrologio. In “Ritratti e incontri” il fantastico libro di Gay Talese (Bur, 2010), il geniale reporter statunitense dedica un racconto memorabile a un certo Whitman, autore anonimo dei necrologi del New York Times tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Racconta Talese che alcuni giornalisti, diffidando probabilmente dei loro stessi colleghi fraterni, preferivano scrivere da sé la notizia della loro morte.
Uno di loro, Lowell Limpus, che lavorava per il New York Daily News, riuscì addirittura nell’impresa di pubblicare il suo stesso necrologio. Apparve con la sua firma nel 1957. E cominciava esattamente così: “Questo è l’ultimo degli 8.700 e più articoli scritti per il News. Sarà di sicuro l’ultimo visto che sono morto ieri… Ho scritto il mio necrologio perché conosco l’argomento più di chiunque altro e perché vorrei che fosse sincero e florido”.
Anche la sincerità è diventata di moda nel giornalismo moderno. Molti lettori sono diventati, nessuno sa come né perché, loro stessi dei giornalisti. Hanno accesso a blog e ad articoli lasciando commenti e opinioni personali in merito. Il che non è male perché il confronto è sempre cosa positiva anche se onestamente penso che nemmeno il visionario Cuco Cerecedo (il giornalista spagnolo strenuo anti-franchista e fedele narratore dei primi passi democratici della Spagna degli anni Settanta, Ndr) avrebbe potuto immaginare che noi, suoi eredi, nel commentare l’attualità avremmo finito per competere con Belén.
Oggi il nostro mestiere si è talmente democratizzato che i nuovi giornalisti non si chiamano più giornalisti. Adesso si chiamano impacchettatori di notizie. I pacchetti vengono elaborati su una immensa scrivania bianca, situata al centro della redazione, su cui si prepara l’edizione digitale. Pare che questa scrivania, priva di cassetti, sia identica in quasi tutti i giornali del mondo. Sarà per questo che la cosa non sembra per nulla improvvisata e forse, chissà, ci vien da pensare che arrivi da molto lontano.
Forse la cosa ha avuto inizio, come quasi tutto quello che ci succede oggi, negli Stati Uniti quindici o venti anni fa. David Simon, creatore della serie The Wire, grande giornalista della cronaca locale del Baltimore Sun, ha spiegato che il concetto di giornalismo moderno è nato a Wall Street con una doppia intenzione: diffondere le nuove tecnologie e indebolire l’influenza della stampa sperando che ciò infastidisse meno il potere.
Simon fu cacciato dal Baltimore Sun e sostituito da due o tre impacchettatori più giovani e peggio retribuiti. Insieme a lui fu dato anche il ben servito a tutti i reporter veterani. In brevissimo tempo, la materia grigia, i saggi del quotidiano, tutti quelli in qualche modo erano legati alle fonti che avrebbero potuto svelare le chiavi della città ai lettori, scomparvero.
Quando il Baltimore Sun perse la sua vera essenza e la battaglia per la qualità, le mafie politiche ed economiche della città proseguirono con i loro affari più impunemente di prima. Non si esclude che tra i prodotti che questi signori vendono oggigiorno ci sia proprio questa enorme scrivania bianca che dirige le redazioni di mezzo mondo.
Oltre alla scrivania, le società di comunicazione che stanno affrontando perdite e incertezze enormi hanno applicato un nuovo concetto di contabilità generale. Più è più e meno è meno.
Ossia, visto che in Internet ci entra di tutto, mettiamoci tutto al minor costo possibile. Tutto tranne la pubblicità a quanto pare. E in attesa che arrivino gli inserzionisti, cerchiamo di farci trovare preparati. Cioè riempiamo. E siccome riempire significa riempire, tutti devono contribuire. Ciò che importa è la quantità. I click. Le visite. Anche se della durata di 20 secondi, l’importante è cliccare.
Dunque oggi abbiamo a disposizione ogni tipo di contenuto, per il lettore più fugace e per il più curioso in assoluto. Abbiamo blog, dibattiti, commenti, Twitter, Facebook, Linkedin, 20 amici da aggiungere, 30 commenti da commentare, due pezzi per la carta stampata e due per il web. Inoltre, se proprio la cosa non ti scoccia e hai del tempo a disposizione, un video, un file audio, una dichiarazione estemporanea per strada circondato da una folla di reporter e una chiacchierata con i lettori…
Dovreste vedere l’espressione dei giornalisti quando si esce a mangiare insieme (adesso ci vediamo al massimo una volta al mese). Le frasi più comuni sono: ”Ci stiamo suicidando”. “Ci stiamo accollando tutta la responsabilità”. Può essere. Ma noi che continuiamo ancora a lavorare dovremmo essere grati. Ancora ci pagano.
Nessuno sa dove andrà a finire questo movimento frenetico. Io ammetto di non averne la più pallida idea. Però con questo guardare avanti, sempre in avanti, ho paura che ci si dimentichi di guardare indietro. E onestamente credo che senza la memoria del giornalismo classico difficilmente potrà esserci modernità.
Omaggio ai maestri. È per questo che oggi vorrei rendere un piccolo omaggio ad alcuni vecchi maestri di questo mestiere. Gente comune, semplice, normale senza nessuna pretesa se non quella di essere persone oneste e bravi professionisti. Gente straordinaria che ci ha aiutato a concepire il nostro mestiere come il miglior del mondo, nonostante tutto.
E comunque diciamocelo, molto meglio fare il giornalista piuttosto che lavorare.
Senza risalire all’epoca dei fenici, inizierei con il periodo in cui iniziai il master a El País. Era il 1990 e Javier García, che dovrebbe essere ancora vivo, una sera mi presentò a Juan Yuste e a Ángel Luis de la Calle, due illustri esempi delle Tre Di che allora erano considerate assolutamente consoni al mestiere: depressivo, dipsomane (tendente a ubriacarsi, Ndr) e divorziato.
Se ci riuscì fu grazie al professor Aranguren, che rimpiango sempre più ogni giorno che passa, che insieme alla mia adorata madrina, Magda, mi incoraggiò a entrare in quella testata che il professore definì incisivamente come “intellettuale collettivo”.
Il primo giorno di lezione fu straordinario. Conobbi doña Mónica che, so che può suonare assurdo, pare sia ancora al mio fianco, e seguimmo la prima lezione di Jesús de la Serna. Dalle Tre Di passammo alle Tre U: “Umiltà, Umiltà, Umiltà”
Grazie ad Angel Santa Cruz che mi impiegò come praticante, riuscì a scrivere e a pubblicare il mio primo pezzo sul giornale. Subito dopo, Julián Martínez, cuore a strisce biancorosse, mi insegnò che non sarebbe servito a nulla imbastire tre pagine se non fossimo stati in grado di ritirare per tempo la foto del signore morto a Palencia e che il fotografo di Zamora aveva mandato tramite una signora di Albacete che sarebbe arrivata nell’arco di… dieci minuti alla stazione di Atocha!
Poco dopo, De la Calle mi volle per l’Edizione Internazionale (EDI) in cui lavorava il grande Carlos Mendo. Mio padre che leggeva tre quotidiani al giorno, battezzò la EDI come “località balneare”.
Poi José María Izquierdo mi introdusse nella sezione Cultura e fui banderillero del maestro Joaquín Vidal durante due fiere di San Isidro. La miglior scuola possibile. Vidal scriveva ad arte persino le didascalie sotto le foto, sosteneva che l’indipendenza del cronista fosse sacra e che non esistevano scuse per sbagliare un dato o arrivare tardi in chiusura. Scriveva articoli di altissimo livello in un garage buio nei pressi di Las Ventas e quando arrivavano in redazione non presentavano né un refuso né una virgola di troppo. E senza Internet, signore e signori!
In tema di indipendenza, don Joaquín era un fanatico: si vocifera che non abbia mai preso un caffè con un torero e che durante le ferie scegliesse sempre l’hotel più economico per evitare di incrociarli.
Poi fu la volta di altri maestri, portatori di stile e saperi ben diversi… Il mio amico José Andrés Rojo, i miei padrini Ángel Fernández-Santos e Angelito Harguindey (immenso aiuto nel controllo del mio lirismo), sua eminenza Maruja Torres e Soledad Gallego Díaz, il sobrio Andreu Missè, l’orefice Fernando Samaniego…
Ma nulla sarebbe stato possibile senza Inés Amado, la mia editrice favorita, e senza Ángeles García che ha dato spazio ad altri maestri, quelli flamenchi, tanto amati dal nostro fondatore, Jesús Polanco. In cinque anni, García pubblicò sei interviste con Morente e quattro con Chano Lobato.
Anche i capi hanno le loro colpe, certo. In particolare Jesús Ceberio che, per tirarmi fuori da Casa Patas, mi mandò a Lisbona come corrispondente e poi Javier Moreno, che ebbe la felice idea di mandare un ateo a seguire il Papa a Roma.
E dunque, prima che questo sproloquio inizi ad assomigliare a un elenco telefonico e prima che i colleghi si accendano una sigaretta, mi fermo qui.
La mia carriera di giornalista la devo per un buon 50 per cento a questi personaggi. L’altro 50 per cento lo devo a Berlusconi. Non esistono molti politici al mondo, né oggi né in passato, capaci di dare così tante soddisfazioni a un giornalista. Come disse il grande Manuel Chaves Nogales, io mi limitai a esserci e a dare prova del fatto che, per questo straordinario mestiere a rischio estinzione, Berlusconi rappresenta due cose allo stesso tempo: un meteorite che cade sulla Terra e l’erba che alimenta i dinosauri.
Raccontare la distruzione di un paese meraviglioso come l’Italia è stato istruttivo e doloroso allo stesso tempo. Ma credo che sia, e continuerà a essere necessario, raccontare come queste cose accadono nel mondo. Con una scrivania grande o piccina, senza connessione o con ADSL da 10 mega, da un garage buio o da Villa Certosa, il giornalismo, o almeno il lavoro svolto da El País in questi ultimi 35 anni, continuerà a essere fondamentale per continuare a vivere in democrazia e libertà.
Perché, come dice un altro splendido maestro che si chiama Miguel Ángel Aguilar, “quando queste cose non si raccontano, si contaminano”.
Grazie.