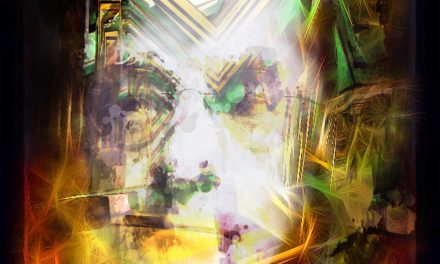Cari lettori,
Cari lettori,
ogni anno, dal lontano 1969, costruttori di armonia si incontrano in ottobre a Rimini per le Giornate internazionali di studio del Pio Manzù, creato dall’inossidabile Gerardo Filiberto Dasi. Il Centro è stato da molti riconosciuto come un ‘Osservatorio mondiale della civiltà contemporanea’ per la sua capacità di previsione dell’evoluzione di scenari globali e per il suo approccio innovatore all’analisi e comprensione dei problemi. Questa 43ma edizione è stata dedicata all’Italia, che ha conosciuto un degrado terribile in questi ultimi anni. Tutti i vecchi cliché che c’erano su questo Paese sembrano rafforzati: ingovernabilità, mancanza di rigore e credibilità dei poteri forti, fragilità economica, incapacità decisionale, espandersi della criminalità e della corruzione. Le categorie della crisi trovano nel “laboratorio Italia” una loro esplicitazione e sintesi. Da tutto il mondo studiosi ed esperti sono arrivati nel Teatro Novelli di Rimini per raccontare la loro lettura del caso italiano e proporre soluzioni, per tentare una via di risalita, per “riveder le stelle”.
Ho seguito le tre Giornate di studio e da oggi vi darò una sintesi degli interventi centrali, indicandovi che gli atti completi delle Giornate, in italiano e in inglese, saranno presto disponibili in un volume prenotabile presso la segreteria del Centro Pio Manzù, 47826 Verucchio (Rimini), tel. 0541.678139, fax 0541.670172, web: www.piomanzu.org. L’immagine d’apertura è tratta dal libro per ragazzi “Italia che storia!”, illustrato da Agostino Traini, Panini Editore. Buona lettura. (s. gian.)
Oggi parleremo della bellezza e di tante altre cose che sono legate alla bellezza, del perché questo nostro Paese ha smesso di essere il Paese della bellezza.
Trent’anni fa Guido Ceronetti nel suo libro “Un viaggio in Italia”, scriveva queste parole: “C’è qualcosa di immorale nel non voler soffrire per la perdita della bellezza, per la patria rotolante verso chissà quale sordido inferno di dissoluzione, non più capace di essere lume nel mondo”.
Sono parole bellissime, perché le uniche ricchezze che l’Italia ha (il suo petrolio) sono i paesaggi, i siti archeologici, i musei, la cultura, tutto da molto tempo sotto l’attacco della speculazione edilizia e del disinteresse generale.
Eravamo i primi al mondo. Nel 1970 eravamo i primi al mondo nella graduatoria dei Paesi per destinazione turistica: oggi siamo scivolati al 28º posto per competitività, ci hanno superato tutti i Paesi europei e molti non europei. I nostri beni culturali sono in condizioni pietose. Da tutti i siti archeologici e da tutti i musei incassiamo meno di 100 milioni di euro, meno della metà del fatturato del solo Metropolitan Museum di New York. È una somma sufficiente a pagare sei mesi di vitalizi ai nostri ex parlamentari; gli introiti annuali del sito di Pompei bastano appena per pagare i vitalizi degli ex Consiglieri regionali del Lazio!
Il consumo del suolo procede a ritmi devastanti: ormai in Italia il 7,3% della superficie non è più naturale. Parliamo di un pezzo d’Italia grande come la Toscana. La media europea è del 4,3%, cioè circa la metà. In un Paese come la Germania, che ha una densità abitativa superiore a quella dell’Italia di circa il 15% e ha un apparato industriale produttivo nettamente maggiore, il consumo del suolo è inferiore, non arriva al 6,8%.
Salvatore Settis, archeologo di fama mondiale, ex presidente del Consiglio superiore dei Beni culturali, attualmente al museo del Louvre, nel suo libro “Paesaggio, Costituzione e cemento”, ricorda che ogni giorno vengono consumati dalla cementificazione 161 ettari, cioè 250 campi di calcio che vengono ricoperti da cose che potete osservare anche qui intorno: palazzine e cose inutili.
Addirittura l’Istat, che certamente non è un’associazione ambientalista estremista, quest’anno con grande preoccupazione ha scritto, nel suo rapporto annuale, che “esiste un grosso pericolo per l’Italia, quello della cementificazione, per gli effetti catastrofici che può causare”.
Non siamo autosufficienti. Se per un caso qualsiasi fossimo costretti a chiudere le frontiere, oggi non avremmo di che sfamare un quarto della popolazione italiana. Non siamo autosufficienti nemmeno più nella produzione dell’olio d’oliva! Una classe dirigente che si rispetti sarebbe molto preoccupata di questa situazione, invece la nostra non lo è affatto. Il governo Monti ha fatto cose importanti; il ministro per l’Agricoltura, Catania, ha presentato un disegno di legge per evitare il consumo indiscriminato del suolo e Monti stesso, quando è stato presentato questo disegno di legge, ha detto che si sarebbe dovuto mettere nel Salva-Italia, però così non è stato. Con il poco tempo che rimane alla fine della legislatura, difficilmente questo provvedimento vedrà la luce.
Al tempo stesso, nei provvedimenti per il rilancio dell’economia non c’è la parola “cultura”, eppure negli ultimi dieci anni i finanziamenti pubblici ai beni culturali italiani si sono ridotti di circa il 50%, mentre il finanziamento pubblico ai partiti aumentava del 1.110%. Siamo arrivati a un livello che è un settimo della Francia, cioè i beni culturali italiani hanno un finanziamento pari a un settimo di quello della Francia.
Mecenati assenti. Arriviamo dunque al punto: ci sono responsabilità enormi da parte della classe politica per questa situazione, che però non sono le uniche, perché c’è anche una responsabilità di una parte della classe dirigente. Dirigere significa dare una direzione e, se non si dà una direzione, significa che non si sa dirigere. Però dirigere significa non solo dare una direzione ma anche dare l’esempio e purtroppo gli esempi che abbiamo ci fanno arrossire. A marzo del 2012 il professor Luciano Segreto, dell’Università di Firenze, ha rivelato che nel 2011 i privati italiani che hanno devoluto delle somme per i beni culturali hanno versato 58 milioni di euro; metà di questa somma viene dalle fondazioni bancarie, quindi non può essere neanche considerato un contributo privato nel vero senso della parola.
I privati tedeschi, cioè imprenditori e capitani d’industria, nello stesso anno hanno dato 4 miliardi di euro, i francesi 370 milioni, gli inglesi 380 milioni.
È uscito un articolo sul Sole 24 Ore circa un anno fa, che ha raccontato come la Tate Gallery ha un’alta percentuale del proprio bilancio che deriva da donazioni private. Nel 2010 il museo inglese ha ampliato la collezione di ben 287 opere, molte delle quali importantissime, provenienti da donazioni private.
Qui invece ci sono enormi difficoltà burocratiche, chissà perché però queste stesse difficoltà burocratiche non si incontrano quando i grandi capitani d’industria comprano le squadre di calcio. Tutti hanno una squadra di calcio: l’aveva Tanzi, l’aveva Cragnotti, l’hanno Berlusconi, la famiglia Agnelli e persino Moratti. Ovviamente le ragioni di questo sono più materiale per sociologi che per altri studiosi.
Rispetto a Paesi dove il ruolo dell’imprenditore privato ha anche una riconoscibilità sociale del proprio ruolo, c’è davvero un abisso. La fondazione creata da Robert Lehman, della Lehman Brothers, che è tragicamente fallita nel 2008, ha regalato 3.000 opere d’arte al Metropolitan Museum.
Il famoso Museum of Modern Art di New York, il MoMA, negli anni ’20 venne fondato per iniziativa della moglie di John Rockfeller. Trentaquattro miliardari americani, tra cui anche Buffett e Bill Gates, hanno sottoscritto un appello per devolvere a opere filantropiche almeno metà del patrimonio accumulato durante la loro vita. Figurano anche nella classifica della Chronicle Filanthropy e nel 2011 hanno finanziato fondazioni e università, musei e opere benefiche, per qualcosa come 430 milioni di dollari. La figlia del fondatore del Wal-Mart ha donato 180 milioni di dollari per fare un museo a Bentonville, nell’Arkansas, una città più piccola di Monterotondo. Cock, multimiliardario azionista della Cock Industries, che aveva già speso molti soldi per il Lincoln Center, ne diede altri perché si potesse allestire una nuova sala dinosauri perché, ha spiegato, “i dinosauri lo affascinavano fin da bambino”. Questo è il segreto, noi abbiamo smesso di essere bambini.
Un piano di recupero. L’Italia rischia di essere travolta dalla globalizzazione anche per questo, nel senso che per la miopia della sua classe dirigente, non ha individuato un proprio ruolo nel mondo globalizzato, che invece molti altri Paesi hanno già individuato. Non sarebbe neanche difficile individuare questo ruolo, ovvero quello di tornare a essere il Paese della bellezza.Certamente la politica potrebbe fare molto da questo punto di vista, per esempio, con un grande piano pubblico di recupero del paesaggio e dell’ambiente. Basta ricordare che Parigi nel dopoguerra ha cambiato volto perché c’è stato un ministro della Cultura e grande scrittore, nel governo De Gaulle, che impose la risistemazione estetica di tutti i palazzi di Parigi.
La storia dell’arte fin da bambini. Alle volte basterebbe veramente poco. Certo, servirebbero interventi profondi per dare un volto nuovo alla città, nell’istruzione, nella ricerca, cominciare a insegnare la storia dell’arte fino dalle scuole elementari, cosa che ci siamo sempre sognato di fare. Certamente senza il contributo delle altre classi dirigenti, gli imprenditori privati, si farebbe veramente poca strada. Mi corre l’obbligo fare un paragone: c’è un industriale americano, mecenate, David Packard, erede del grande impero dell’informatica della Hewlett Packard, che negli ultimi dieci anni ha speso 16 milioni di euro per risollevare la situazione del sito archeologico di Ercolano, l’unico dei siti archeologici italiani che, grazie al suo intervento, ha ricominciato ad aumentare i visitatori (parlo dei siti riconosciuti come patrimonio dell’Unesco) mentre tutti gli altri ne stanno perdendo. Mentre David Packard spendeva 16 milioni di euro per Ercolano, noi avevamo un grande industriale, un grande petroliere, che spendeva 18 milioni di euro per pagare la campagna elettorale di sua moglie, che tra l’altro non è neanche stata fortunata al secondo turno.
Dopodiché abbiamo assistito a polemiche a non finire perché un altro imprenditore aveva deciso di dare 25 milioni di euro per il Colosseo e si stava già facendo saltare questa cosa, con il motivo che bisognava fare una gara. Io mi sono sempre domandato se non ci fosse un pizzico di follia che agitava queste polemiche, dal momento in cui noi non abbiamo neanche i soldi per tappare i buchi che si stanno aprendo nella Domus Aurea a Roma.
Per non parlare dell’auto: i vertici della Fiat sono convinti che in Italia non si possano più fare automobili e probabilmente è vero, ma dipende da quali automobili. Certo, se parliamo delle utilitarie peggio di quelle coreane, oppure di certi cassoni americani a cui hanno messo lo scudetto della Lancia sul cofano, allora sono d’accordo con chi dice che non si possono più fare.
Se però la Volkswagen ha offerto alla Fiat di acquistare l’Alfa Romeo, per produrla non in Polonia ma a Mirafiori, questo vuol dire che le automobili in Italia si possono fare, bisogna solo capire quali. I tedeschi hanno già acquistato la Lamborghini che, quando è stata comprata, produceva 70 auto all’anno e adesso ne produce 700. 700 auto Lamborghini sono come 70.000 Fiat, per capirci.
Audi ha speso 860 milioni di euro per rilevare la Ducati, anche qui non per produrla in Polonia ma a Bologna, come gli stabilimenti della Lamborghini sono a Sant’Agata Bolognese, dove c’è l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che spaventa tanto i nostri industriali. Il motivo è che la Ferrari è Ferrari solo se esce da Maranello, non se viene fabbricata in Algeria.
Questo lo sanno i tedeschi, lo sanno i giapponesi e anche i cinesi, dove i ricchi che si potranno comprare una Ferrari a breve saranno 200 milioni. Il gruppo Fiat mi sembra produca 3 milioni di auto all’anno, compresa la Chrysler, per avere un’idea.
La bellezza tiene insieme tutto. La bellezza tiene insieme tutto: i beni culturali, il paesaggio e i siti archeologici, il clima, il cinema, la cucina, l’architettura, la moda, il design e la tecnologia, l’industria dell’auto e tutte le cose bellissime che potremmo produrre con tecnologie molto avanzate. Sarebbe incosciente non capire che il nostro ruolo nel mondo globalizzato non può essere che questo, quello del Paese della bellezza.
* Sergio Rizzo è scrittore e giornalista del Corriere della Sera. E’ coautore, con Gian Antonio Stella, del volume: Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia. ** Prossima puntata: Dal FAI al fare: un esempio, e i fondi, per ripartire (di Anna Maria Barbato Ricci).